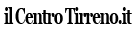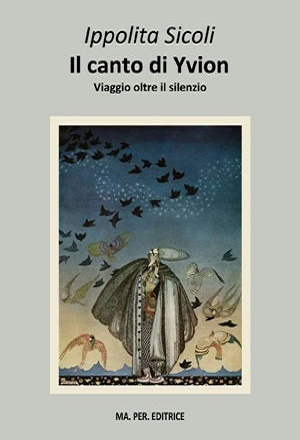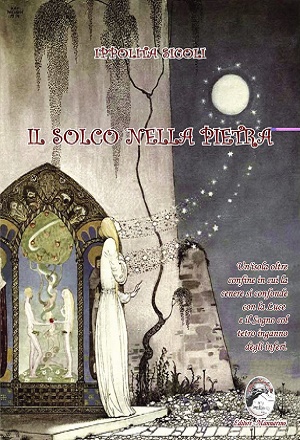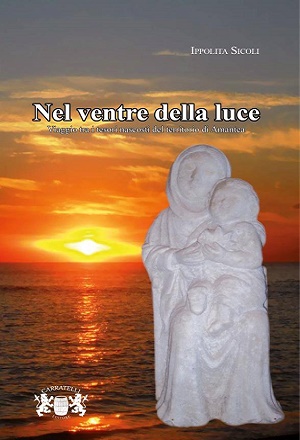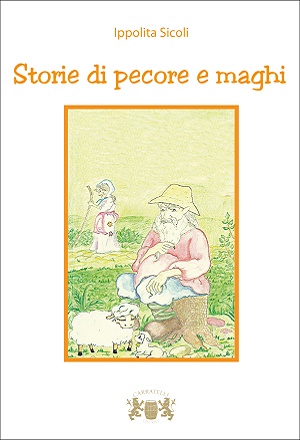Il seducente mondo della donzella e il declino dell'aristocrazia. Da Manzoni a Fogazzaro
La semplicità come qualità dell'umiltà è uno dei temi centrali de "I promessi sposi" e, per quanto trainante nella trama dei romanzi ottocenteschi, il Manzoni lo fa rientrare nell'ambientazione del Seicento. La "ius prime noctis" di tradizione medievale e ahimè perpetrata nei secoli da una certa nobiltà che ha costruito il suo potere sull'oppressione degli ultimi, ha continuato a tramandarsi nello specifico nelle aree più represse del Meridione con la figura del massaro e con le baronie filoborboniche. Il merito del Manzoni è quello di aver portato alla ribalta seppur con lo stile e il garbo che si addicono a un grande narratore, un tema vergognosamente attuale ai suoi tempi e di forte ostacolo ai tentativi di ammodernamento della società, in cui lui credeva e a cui ha fortemente contribuito.
La donzelletta leopardiana rende l'idea non della giovinetta frivola di palazzo, ma dell'allegra spensieratezza che accompagna il rientro prima del dì di festa della sbarazzina campagnola. Il mondo della Natura è un tutt'uno magnifico, il concentrato visibile di un'anima sola ripartita nei suoi singoli componenti che appaiono riuniti come in un'unica famiglia. È questa l'idea della campagna lavoratrice che ci ha tramandato la cultura sensibile dell'Ottocento, scucendoci un forte affetto nostalgico e una sana commozione al pensiero di un mondo ormai estinto e che qualcuno al tempo d'oggi tenta disperatamente di riportare in vita.
La donzelletta freme della giovanile gioia che caratterizza tutte le giovani creature che vanno incontro alla vita come fosse un arcipelago di lidi azzurri. C'è la speranza e l'attesa di quelle tappe semplici che colmavano di luce il cuore di ogni donna. Il primo sguardo, il primo incontro, una lunga schiera di baci sul muricciolo al canto dei grilli nelle serate di luna piena e poi, l'abito bianco e il fatidico sì.
La speranza era questo e glielo si leggeva negli occhi affascinati dalle storie di sorelle e amiche più grandi che riferivano in modo fantasioso le loro più intime confidenze.
Le movenze di danza delle giovani contadine, regine festose dei campi componevano l'immaginario di una seducenza antica che si rintracciava nelle antiche dee agresti, miraggio degli uomini incantatori e seduttori. Il mito di Diana e Atteone ripropone l'istinto maschile del cacciatore che cerca l'inafferrabile e non si da' pace finché non l'avrà ottenuto, pur finendo nel mito distrutto.
Cosa spingeva il giovane rampollo nobile a rapire e stuprare una vergine agreste? Sentirla palpitare e fremere come un cerbiatto braccato, avvertire sotto i polpastrelli il pulsare della vita genuina e calda. Più di tutto era il desiderio di lasciar scorrere nelle vene tracce di una spontaneità usurpata con violenza e rabbia perché mai posseduta. Questo coincide con quanto realmente accadeva una volta ai bordi del mondo racchiuso e vivace della campagna.
La "Ius prime noctis", lo stupro di una giovinetta semplice e integra quale un bocciolo di rosa che sorride al sole madido di rugiada, significavano prendere con forza ciò che a chi credeva di possedere tutto, il destino aveva negato. E destino e natura all'interno della ricca proprietà coincidevano.
Il nobile ottocentesco era l'escluso. Colui che poteva limitarsi a guardare dalla cornice del riquadro della finestra quanto spontaneamente avveniva nel mondo della Natura dove nella durezza dei giorni vissuti con intenso lavoro la lietezza non si arrendeva mai e sempre si levava col giorno un canto di donne da in fondo alle distese di grano o dai rami grondanti degli ulivi. Nulla a che vedere con le costruite suonate al piano accompagnate dal soprano di turno nei salotti delle piccole corti di palazzo, o con le voci nutrite di compostezza e di educazione affettata delle dame che venivano di volta in volta introdotte dalle famiglie alle importanti feste su invito. Lì si poteva scegliere e ottenere facilmente l'accondiscendenza, così come avvicinare le proprie simili per convenienza, in un mondo immobile che si riciclava di continuo in un teatrino da pari a pari, dove non era necessario usare la forza e dare sfogo alla bestialità repressa.
La violenza accadeva ed era la normalità alle giovani braccianti o operaie delle aziende di campagna. E laddove certi episodi non erano guidati dalla tracotanza del ricco possidente, erano la conseguenza del malinconico epilogo della civiltà aristocratica che avrebbe ceduto da lì a poco lo scettro alla sopraggiunta borghesia che andava organizzandosi in capitalismo. Fogazzaro nel suo romanzo "Piccolo mondo antico" da' voce a una nuova realtà in cui per tramite dei sentimenti il ceto aristocratico e quello popolano vanno intrecciandosi e seppur tra mille difficoltà, riescono a trovare l'intesa. Per l'autore che riporta la vicenda agli anni difficili dell'unificazione nazionale e della nascita della nostra Italia, il piccolo mondo antico è quello sempre più ristretto e isolato dell'aristocrazia e dei suoi ultimi baluardi restii ad abdicare alla nuova configurazione sociale. È un mondo che finisce e svanisce, rappresentato dallo zio del protagonista che muore su una panchina.
Gli abusi sugli ultimi non sibestingyeranno col finire dell'Ottocento. Proseguiranno e varcheranno la soglia dell'era contemporanea, attualizzandosi attraverso il caporalato. Donne sottomesse e violentate, giovani sfruttati... non è crollata l'aristocrazia impavida, ha semplicemente mutato aspetto nascondendosi nel rozzo contadino possidente o nel giovane imprenditore titolare di una piccola azienda. Cambiando volto, la storia si ripete.
https://images.app.goo.gl/uyLLG6RqvD12x3iG7