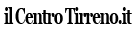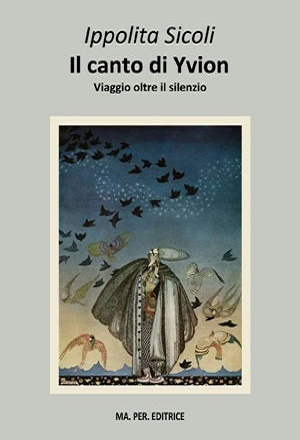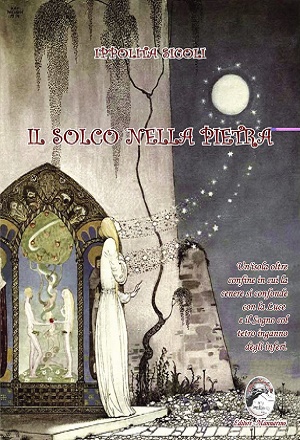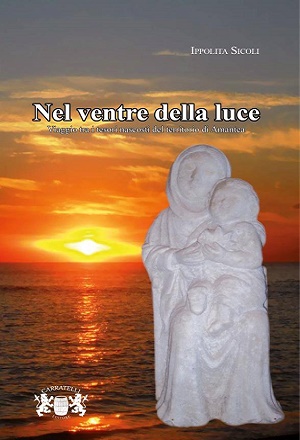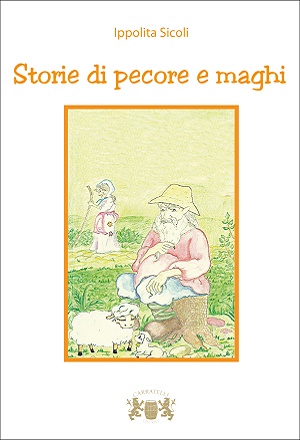Il concetto di semplicita’ ci riconduce inevitabilmente a un’imnagine di vita frugale che confligge con la dimensione urbanizzata dell’uomo e dell’idea di civilta’ piu’ evoluta.

Con l’avanzare del progresso anche gli archetipi subiscono sul piano immaginifico un cambiamento che li porta ad attualizzare il linguaggio dell’arcano imprimendovi i contorni di una moderna complessita’. Il bosco, la notte rispolverano le loro intrinseche insidie slittandole sul piano semantico e piegandole a una quotidianita’ implementata da questioni sociali altamente condizionanti e dalle quali l’uomo si lascia invischiare e sedurre. La rosa ancestrale di simboli conquista altri referenti e trova sfogo nell’incompiuto attraverso gli espedienti estetici. L’arte acquisisce quindi quella totalita’ espressiva che la porta a immortalare anche gli aspetti gravi e inquietanti dell'anima, riflettendoli come uno specchio. Se è compito della fotografia emergente nella seconda meta’ dell'Ottocento convogliate nella dimensione sociale i connotati appetibili della dimensione umana, imponendosi per la sua franca immdiatezza, l’arte, e in particolare la ritrattistica, e’ il risultato di un dialogo taciuto tra l’artista che vi imprime la sua visione del mondo e i tratti in ombra (o al contrario esaltati nella luce) propri del soggetto rappresentato.
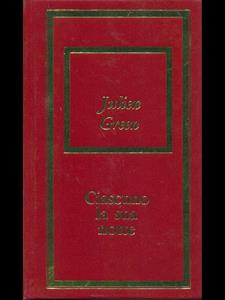
La pittura novecentesca non e’ piu’ fedele riproduzione della realta’ ma impressione ammaliatrice di raptus cognitivi in cui l’intuizione guida la mano sensibile. Il divario tra essere e apparire sfonda il sipario delle camuffate rappresentazioni per divenire in letteratura inquietante scacchiera in cui l'io sociale calpesta gli orridi e refrattari aspetti della psiche. Il doppio e’ una componente non solo dell’ironia cavalcata dalla commedia satirica sull’insorgente borghesia capitalista, ma diviene nelle sue pennellate piu’ tragiche espressione di un’ambigua bivalenza che si accentua nelle trame dei romanzi, spogliado l’anima dei protagonisti e risolvendosi nella morte.
L'esperienza didattico formativa dei soggetti narrati nei romanzi basati sulla struggente dicotomia appena accennata, approfondisce i solchi della coscienza che sprofonda in turbinose esperienze, portando il lettore oltre i confini del giudizio, a interrogarsi sui piani della coscienza.
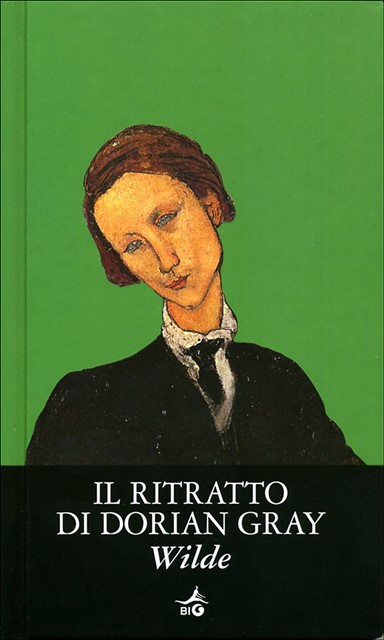
Il ritratto di Dorian Gray di O.Wilde e Ciascuno la sua notte di J.Green, seppur ascrivibili a periodi diversi, innescano altre problematiche sul nodo irrisolto della bivalenza societa’ interiorita’. La penna artistica di Wilde viene sorpassata dal taglio moralistico e religioso del secondo romanzo in cui il tema dell’omosessualita’ consente l'accesso ad esperienze che mortificano l’anima fino a sacrificarne l’esistenza. L’arte sopravvive alla vita e’ invece il messaggio finale lanciato da Wilde nel suo romanzo in cui l'autore sembra smembrarsi in ciascun personaggio per dar voce all'Estetismo di fine Ottocento. Il ritratto cattura l’anima eternandola attraverso la metafora della giovinezza e l’autore impersonato da Dorian riattualizza il mito di Narciso, infondendogli nuove chiavi di interpretazione estrapolate dall’intricato quanto affascinante mondo della psicanalisi da poco introdotto ed esplorato.