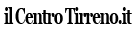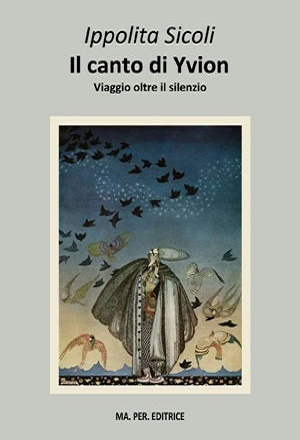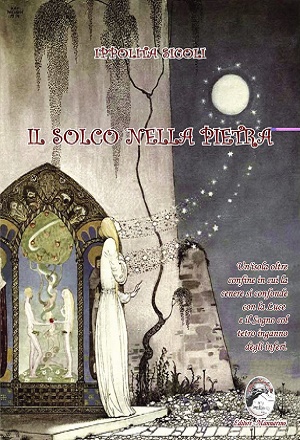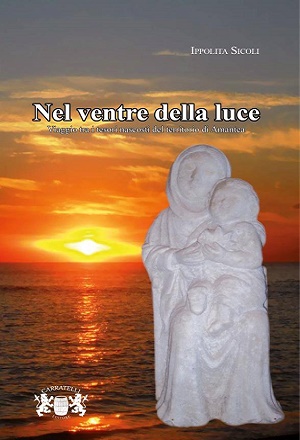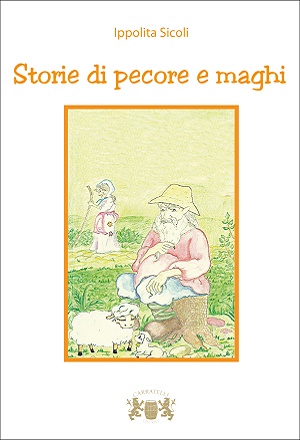Il lato migliore di una frase o di un'intera opera consiste nel fatto che ognuno può riconoscersi in essa, in loro, pur sapendo di non essere il reale destinatario.

È una finzione eccelsa la vera opera artistica, perché ognuno si scopre fruitore o agente fittizio nelle vesti del suo creatore. La realtà si spoglia attraverso gli occhi di tutti e si riveste tramite il pensiero di colui che la rende viva. È primavera e autunno, insaziabile vita che non smette mai di fluire da uno sguardo all'altro e di proseguire il suo cammino nel tempo. Per questo un'opera non conoscerà mai morte, ma vivrà del respiro di chi saprà leggerla e interpretarla.
È uno specchio che non riflette mai la vecchiaia, in quanto capace di racchiudere le infinite età dell'uomo. Oltre le stagioni della vita esistono altri tempi che noi non sperimentiamo nel quotidiano, perché distratti, e che invece viviamo con la lettura di un'opera. Esiste il tempo in cui non siamo solo noi stessi ma anche i personaggi che si muovono nella trama dell'opera. Siamo insieme infanti e saggi, crudeli manipolatori e altresi' innocenti anime. Vittime e carnefici, stabilendoci così in una stagione fuori dalla realtà che riempie il nostro tempo. Se nella quotidianità viviamo un solo tempo, nell'opera d'arte siamo infiniti in un tempo infinito che rende vera l'opera.
Nelle opere eccelse, come ad esempio la Divina Commedia di Dante, noi siamo anche il prodotto di quanti l'hanno interpretata e commentata, dando vita a uno specchio nello specchio attraverso il quale noi oltre a vedere noi stessi e il sommo poeta, vediamo i tanti che si sono cimentati nella sua analisi, sempre parziale e imperfetta rispetto al pensiero originario. L'opera eccelsa è quindi una finestra nella finestra, una summa dei singoli capitoli di vita dell'uomo racchiusi dallo scibile umano che in colui che avverte nella penna l'ispirazione divina è un cielo a volto aperto, con le numerose ombre dettate dalla perfettibilita' umana in corsa con l'esigenza di Assoluto. Quanto piu’ l’opera viene analizzata e reinterpretata, tanto piu’ appare superlativa, mentre ne escono ridimensionate le singole letture. Dante nella sua Divina Commedia incide la propria firma nel cuore di ogni singolo verso ricorrendo all’uso in voga nel Mecioevo della figura retorica dell’allegoria.
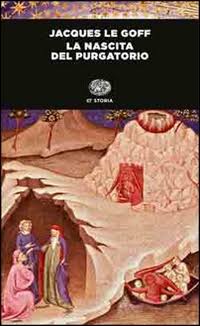
L’allegoria rende plastico e diretto il messaggio che il Sommo lancia. Un messaggio dal significato unico e non polivalente utilizzato non a caso dalla Chiesa medievale. L'allegoria prepara il lettore a un mondo ordinato secondo precise clausole divine. Il Cosmos filosofico attinge concretezza dal rapporto non di causalita’ astratta, ma di causalita’ escatologica che obbedisce alla Luce Suprema. A tal proposito non è riduttivo cogliere nella più grande opera dantesca l'impronta stigmatizzate delle fedi monoteiste, nonostante la presenza illuminante della cultura pagano greca e latina. Il trionfo del credo monoteista è ravvisabile nella scansione precisa delle tre cantiche, nella manicheistica contrapposizione del bene al male e nel riscatto di quest’ ultimo attraverso il regno del Purgatorio che, subentrato nell’immaginario collettivo nel Vll sec.d.C. va a smussare il netto dualismo bene-male, conferendo maggior potere alla Chiesa (vedi di J.LeGoff La nascita del Purgatorio).
Nel poema di Dante l’impianto verticistico a scala suggerisce l’influenza delle culture mediorientali teocratiche, ammorbidite da una trattazione che non preclude, anzi investe le eretiche scuole di provenienza. Ne vien fuori un intricato e laborioso firmamento a chiazze di luci ed ombre in cui l’elemento punitivo di appannaggio medievale riesce a convivere con temi di una modernità ancora sfuggente.
La Divina Commedia e’ quindi piu’ di una staordinaria opera filosofica o summa pedagogica. È un Universo labirintico in cui il nozionismo spesso si scontra con i limiti della presunzione edotta, lasciando emergere la spontaneita’ libera da ogni costrutto mentale e nutrita di quella sensibilità che ancora sparge il mondo di incantevoli fiori.